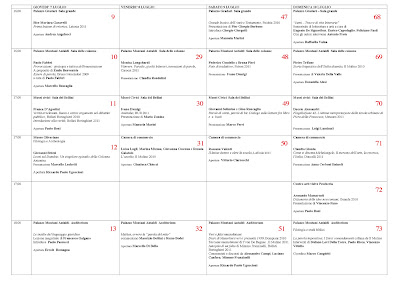Un racconto ispirato alle Argonautiche: in
viaggio sulla nave di Orfeo, cercando le creature metà fanciulle e metà
pesci e il loro prato marino tra gli scogli, con gigli e viole
Dall’Eden alle Sirene: la serie estiva di Tuttolibri
prosegue con un racconto che prende spunto dalle Argonautiche orfiche
, poema bizantino posteriore alla metà del V secolo d.C. in cui il protagonista delle imprese della nave Argo non è più Giàsone ma Orfeo.
La voce narrante del racconto è quella di Bute, il cui episodio si rintraccia in Apollonio Rodio.
Nell'isola delle sirene
fiorisce l'immortalità
"La sirena Lighea" (1873) dipinta da Dante Gabriel Rossetti
SILVIA RONCHEY
Ogni giardiniere sa che il principio di ogni giardino è la morte. E’ dalla putrefazione e dalla decomposizione più amara che nascono i fiori più dolci, le orchidee più delicate, le rose più profumate, le viole dalle striature più cupe, che trascinano nel vortice dello stame come al fondo del pozzo sul cui orlo si sporgono. Posso annegare in una viola, perdermi nel labirinto di un’orchidea, sciogliermi nella pura contraddizione di una rosa.
Sono affascinato dai giardini più che da ogni altra forma di bellezza, perché sono il perfetto punto di congiunzione tra la bellezza e la morte. Mi chiamo Bute, sono un viaggiatore. Prima di imbarcarmi sulla nave di Orfeo ho girato il mondo, ho visto i giardini pensili di Babilonia, gli orti che gli egizi circondano di alte mura per preservarli dalle tempeste di sabbia, i cortili minoici striati di croco. Conosco il parco dove si riuniscono i discepoli di Socrate, il recinto ombroso dei seguaci di Epicuro, i tetti fioriti in onore di Adone, i ninfei circondati di statue e le esedre traboccanti di campanule e gigli. Ho visto signori prodigarsi per le loro ville sulle coste ausonie o sulle spiagge libiche, frustare i loro giardinieri e offrire sacrifici a Flora perché le terrazze in pendio sul mare fossero tappezzate di dalie fiammeggianti come soli o di ortensie livide come lune. Gareggiavano tra loro, e con la natura genitrice di tutto. Ed erano sempre insoddisfatti.
Poi, nel sud dell’Egeo, ho visto gonfiarsi all’equinozio rose gigantesche, i cui mille petali spalancati emanavano un profumo che stordiva chiunque costeggiasse quelle rive. Ho capito che i fiori più belli non possono essere coltivati, ma devono emergere spontanei dal ciclo inesorabile dell’essere. E che per questo, se nulla può eguagliare la bellezza di un fiore selvaggio, il giardino più bello è quello il cui artefice è la morte.
Sono più goloso dell’ape attica, cara ad Atena, più vibrante dello scarabeo dal verde guscio, sacro agli egizi. Per me il sentore di un fiore è più complesso di qualsiasi melodia scaturita dal flauto o dalla lira, più plastico di qualsiasi forma scolpita da Apelle o da Fidia.
Avevo sentito parlare di un giardino, che è il giardino dei giardini. Cresce su un nudo scoglio proteso nel mare, la punta di un promontorio dove la roccia si tuffa a precipizio dall’alto. Alcuni la chiamano Anthemoessa, l’Isola dei Fiori. Come gli insetti gremiscono le rose e ronzano creando una melodia che ipnotizza e rapisce, così in questo giardino ammaliano i marinai col loro canto strane creature, per metà fanciulle, per metà pesci secondo alcuni, uccelli secondo altri, in realtà grandi insetti dalle code iridate e traslucide, come quelli che precipitano dal cielo insieme agli angeli ribelli.
Alcuni le chiamano Sirene, e il loro nome, seirén, è infatti uguale a quello che in greco designa alcune api solitarie. Secondo altri viene dal verbo seiráo, «lego», e allude al nesso tra tutte le cose, o da seirá, «catena», la grande catena dell’essere. Come che sia, la vibrazione irresistibile che emettono è in qualche modo simile alla musica degli astri. Platone, nel racconto di Er, parlando del fuso che vortica sulle ginocchia della Necessità, ha detto che l’armonia delle otto sfere celesti si fonde nel suono della voce continua, incessante delle Sirene.
Si sa che è destinato a non fare ritorno chiunque si tuffi dalla nave vinto da quel canto. Ma a vincermi non è stato il canto. Orfeo, dritto sulla prua, lo aveva messo a tacere. Con la sua cetra, che detta ordine a ogni creatura, aveva vinto e umiliato le Sirene. A paragone dell’incalzante armonia di Orfeo, il loro era diventato un gemito indistinto. Non sono stato sedotto dalle Sirene, non mi sono tuffato dalla nave per il loro canto. Volevo vedere il giardino.
I fiori che nascono nel prato tra le rocce scoscese, e si specchiano e moltiplicano nell’infinita lente del mare che l’aratro non solca, li immaginavo simili a quelli che secondo i giudei adornano il giardino dell’Eden, o forse a quelli dei cimiteri dei cristiani. Perché, come Circe ha rivelato a Odisseo, nascono da uomini marciti. Perché le sirene dalla voce di miele non si nutrono di altro animale che non sia l’uomo. Ed essere il migliore dei concimi è una delle non molte qualità che rendono superiore agli altri animali il bipede implume che chiamiamo uomo perché, stando ai latini, è fatto di terra, humus, e lì ritornerà.
Tutto va sotto terra e rientra in gioco. Un gran mucchio d’ossa, la pelle che scompare, esseri umani fusi in una spessa assenza. Nel prato marino le ossa erano in putrefazione, l’argilla rossa aveva bevuto il loro biancore e il dono di vivere era passato ai fiori. Grandi gigli purpurei, grandi gigli rosati schiudevano corolle odorose dai bordi dentellati; i calàdi dispiegavano foglie policrome filigranate d’oro bruno, cesellate d’oro verde; le viole si gonfiavano tra fogliami gladiolati; le bromeliacee rizzavano le loro spate enormi come sessi impudichi. Intorno, il cielo cantava all’anima consunta gli scogli mutati in rumore. Come diceva il mio compagno di remi sulla nave di Orfeo, anche noi saremmo divenuti canto.
E’ così che ho deciso di farmi divorare, perché la decomposizione del mio imperfetto corpo mortale contribuisse alla perfezione dell’unica bellezza immortale, che a ogni stagione si ricrea sempre sublime e mai uguale: la bellezza del giardino.
Credetemi, è questa l’immortalità. Non quella di Odisseo, che alle Sirene ha resistito spalmando le orecchie di cera. Non quella di Giàsone, che ha evitato l’Isola dei Fiori per conquistare il Vello d’Oro. Loro sopravvivono nei versi dei poeti, ma sono carta, segno, effigie, immagine di un’immagine — io disprezzo la letteratura. Io mi sono dato alle Sirene come il Buddha alle tigri. Narciso, che amava se stesso, è diventato un fiore. Io, che non amo porre confini tra me e il mondo, mi sono fatto giardino.
www.silviaronchey.it
(fonte:
Tuttolibri, sabato 9 luglio 2011,
La Stampa, pagg. I e IV)